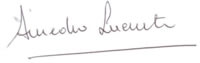L'angolo della lettura
06/04/2024 - Pandemie: una storia già vista
Lo studio delle pandemie del passato e di quella attuale, il riscontro di comuni assonanze, e la constatazione delle inevitabili differenze, possono offrire energici spunti non solo speculativi per acquisire maggiore consapevolezza verso l’immane catastrofe sanitaria che stiamo vivendo. Purtroppo impreparati, per molti versi spauriti e impotenti, nonostante il progresso scientifico, vediamo ancora lontano la fine del tunnel che stiamo percorrendo. Le nostre attività quotidiane non sono più libere nelle relazioni e nei movimenti, ma inevitabilmente dettate dal timore del contagio, dal considerare come un possibile Covid positivo ogni nostro interlocutore. La nostra esistenza, per molti versi influenzata dal pericolo del contagio, continuerà comunque il suo percorso. In futuro tuttavia, con modalità e caratteristiche differenti, molti nostri atteggiamenti muteranno e saranno caratterizzati, per un tempo non prevedibile, dalle precauzioni dettate da questa prima, inaspettata e travolgente pandemia del Terzo Millennio. Infezione, influenza, epidemia, endemia, pandemia, pestilenza, sono spesso accomunati nel concetto di malattie che interessano un gran numero di persone. Il coronavirus, causa di questa pandemia, identificato in Cina e poi arrivato in tutto il mondo, con milioni di contagi e 4.063.453 morti, nonostante la somministrazione di 3.402.275.866 al 15/07/21, ha fatto riemergere la paura delle pandemie su larga scala, portandoci indietro nella storia. L'11 marzo 2020, l'OMS Organizzazione Mondiale della Sanità, che in un primo momento aveva considerato l’infezione da coronavirus come epidemia, ha riclassificato il Covid-19 ufficialmente come pandemia.
- Infezione (dal latino, mescere una sostanza in un’altra,
imbevere, tingere, anche come figurativo corrompere, avvelenare, inquinare).
Perché sussista un’infezione deve realizzarsi la relazione tra due esseri
viventi: un agente infettante e un ospite infettato. Nell’infezione si prevede
un contagio, una contaminazione attraverso microrganismi, virus, batteri,
miceti, funghi, protozoi, parassiti, vermi o acari. In alcuni casi i
microrganismi entrano nel corpo dell'ospite tramite vettori, in genere insetti
come zanzare o pulci.
- Influenza (dal latino, scorrere d’entro, insinuarsi,
inondare). Malattia infettiva respiratoria acuta causata dal virus
dell'influenza a RNA della famiglia Orthomyxoviridae. Con epidemie annuali,
coinvolge da tre a cinque milioni di persone, con 250.000-500.000 morti. Per la
dottrina miasmatico umorale, per secoli condivisa, gli uomini si infettavano
per diffusione nell'aria di miasmi, particelle velenose.
- Epidemia (dal greco, sopra il popolo, che incombe sopra il
popolo, che riguarda il popolo, diffusa tra il popolo). Malattia infettiva che
colpisce nello stesso momento più individui della medesima comunità. Ha
carattere brutale, improvviso, massiccio, spettacolare, temporaneo, come
riferisce la Treccani. Se il territorio colpito è poco esteso, si utilizza
l’espressione “focolaio epidemico”. L’omologo dell’epidemia negli animali è
l’epizoozia (o enzoozia), nelle piante l’epifitia.
- Endemia (malattia diffusa nel popolo, nella regione).
Epidemia presente costantemente in una determinata area geografica che si
ripete nel tempo, come la malaria e talassemia. Si possono avere imprevedibili
accelerazioni epidemiche, com’è successo per la malaria in Madagascar nel 1988.
- Pandemia (dal greco, di tutto il popolo). Epidemia
particolarmente estesa a tutta la popolazione. L’OMS parla di pandemia quando
in più Paesi avvengono epidemie con trasmissione veloce, non necessariamente in
relazione con il focolaio originario, caratterizzate da particolare resistenza,
aggressività dell'agente patogeno, facilità di trasmissione diretta o
indiretta.
- Pestilenza (dal latino, pestilente). Particolare tipo di
epidemia in cui la malattia è la peste.
Nel passato si
pensava che le malattie fossero espressione di forze soprannaturali, dell’ira
delle divinità verso il popolo. Ippocrate, nel V secolo a. C., ipotizzò come
cause delle epidemie squilibri all’interno del nostro corpo dei quattro “umori”
che lo costituivano: bile nera, bile gialla, sangue e flegma (flemma, catarro,
muco delle vie respiratorie). Questa teoria è stata accettata fino alla metà
del XIX secolo. Molto accreditata nell’ambiente scientifico di quell’epoca, la
cosiddetta “teoria dei miasmi”, attribuiva la capacità di minare la salute
umana alle più varie condizioni ambientali, come sporcizia, inquinamento,
incauto utilizzo di acque stagnanti, all’unisono influenzate,
imponderabilmente, da imprecisati fenomeni atmosferici. Bisogna arrivare alla
fine del Seicento con il lavoro di Antoni van Leeuwenhoek (noto anche come
Anthonie, Antony van Leeuwenhoek, 1632-1723), ottico e naturalista olandese
perché, grazie al suo primo microscopio, si formulasse l’ipotesi che le
epidemie fossero dovute a esseri viventi invisibili a occhio nudo. Il suo
strumento permise, grazie ad una risoluzione 270 volte superiore rispetto ad
altri microscopi esistenti, l’osservazione per la prima volta dei microrganismi.
Membro della Royal Society di Londra, ne fece proprio il motto oraziano
“Nullius in verba”, e applicò il metodo sperimentale nella ricerca, facendo
derivare i risultati dei sui studi dai riscontri piuttosto che da mere
supposizioni. Bisogna aspettare infine la metà dell'Ottocento per attribuire
definitivamente ai batteri la causa delle epidemie.
Una delle prime
pandemie di cui abbiamo notizia storica è la febbre tifoide che si è verificata
durante la guerra del Peloponneso, tra Atene e Sparta (431 – 404 a.C., V secolo
avanti Cristo), conosciuta come “peste di Atene”. Colpì in poco tempo la
popolazione di gran parte del Mediterraneo orientale. Considerata inizialmente
come peste bubbonica, altre fonti hanno ipotizzato come cause il tifo, il
vaiolo, il morbillo o sindrome da shock tossico. Ricerche successive, sulla
scia degli scritti di Tucidide storico e militare ateniese, fanno risalire
l’origine all’antrace diffuso di origine africana. Altre fonti ancora associano
quell’epidemia al virus dell’Ebola o alla febbre emorragica, gruppo d’infezioni
virali altamente contagiose caratteristiche dell'Africa, Asia e del Sud
America, ancora oggi relativamente poco conosciute. Tra le febbri emorragiche,
oltre l’Ebola, si annoverano: Marburg, Febbre di Lassa, Dengue e altre dovute
ad arenavirus.
Nel gennaio 1999 uno studio dell'Università
del Marylan è giunto alla definitiva conclusione che la malattia che uccise i
greci e il loro capo militare e politico, Pericle, fosse tifo esantematico. A
questa prima e documentata pandemia ne sono seguite tragicamente altre: il
morbo di Giustiniano (541d.C-767d.C.) e, per molti secoli, la Peste Nera
(1347-1351) e le pestilenze del Seicento, mirabilmente descritta dal Manzoni
nei Promessi Sposi. Nel Ventesimo Secolo EpiCentro, portale epidemiologico a
cura dell'Istituto Superiore di Sanità ISS, riporta tre grandi pandemie
influenzali: nel 1918, 1957, e nel 1968, denominate Spagnola, Asiatica e Hong
Kong, in base all’area geografica di presunta origine, causate da tre sottotipi
antigenici differenti del virus influenzale A, rispettivamente H1N1, H2N2, e
H3N2.
L’umanità è stata afflitta sempre da grandi
pandemie: il punto per il futuro è non essere noi umani a provocarle. Molti
comportamenti e discutibili stili di vita, con tutta probabilità, sembrano
essere le cause di questa pandemia. Le abitudini alimentari, che continuano
nonostante il contagio, per non pensare ai “complotti” di laboratorio, sembrano
purtroppo inesorabilmente incolparci, senza alcun appello.